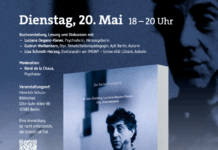Un pappagallo australiano tra le miniature del De Arte venandi cum Avibus
A scuola abbiamo imparato che in natura ci sono tre grandi regni – animale, vegetale e minerale – e che in ciascuno di essi la vita pulsa, anche se con intensità molto variabile. Nel regno animale gli uccelli sono la sola classe di vertebrati in grado di volare. Questa capacità gli consente di coprire notevoli distanze, nel caso degli uccelli migratori perfino migliaia di chilometri, senza mai toccare terra. I pappagalli non sono uccelli migratori e non vivono in Europa. Otto secoli fa uno di loro, il cacatua dal ciuffo giallo (cacatua galerita), finì tra le miniature del De Arte venandi cum Avibus, il libro di falconeria scritto dall’Imperatore Federico II di Svevia.
Il cacatua dal ciuffo giallo vive nell’Australia settentrionale, orientale e sudorientale, in Tasmania, nelle isole Palau, su alcune isole delle Molucche meridionali e in Indonesia. Poche altre specie di pappagalli hanno un’area di distribuzione altrettanto ampia. Probabilmente ciò si deve al fatto che sono molto longevi: in natura vivono fino a 60 anni, in cattività fino a 80. A Sydney i cacatua dal ciuffo giallo la fanno da padrone, sono curiosi e invadenti come e più dei nostri colombi. Ma come è potuto accadere che il cacatua abbia fatto la sua comparsa nel manoscritto dello Stupor Mundi e, soprattutto, chi e come si è accorto della sua presenza tra le centinaia di specie descritte?
A occuparsi in chiave storico-geografica del simpatico pappagallo australiano è stata la ricercatrice Heather Dalton dell’Università di Melbourne. La sua indagine inizialmente ha avuto come oggetto un uccello collocato da Andrea Mantegna nella Madonna della Vittoria, pala d’altare dipinta nel 1496 a Mantova ed oggi esposta nel Museo del Louvre a Parigi. Nel suo articolo “Un cacatua dal ciuffo di zolfo nella Mantova del XV secolo: ripensare i simboli di santità e i modelli di commercio” (2014) la Dalton, dopo aver riconosciuto il pappagallo australiano nell’opera del Mantegna, ha concluso che la sua rappresentazione ha messo in luce “la complessità e l’ampiezza delle reti commerciali del sud-est asiatico prima del contatto diretto con gli europei” confermando gli interessi e il potere d’acquisto dei committenti di Mantegna, i Gonzaga.

Secondo la ricercatrice australiana, Mantegna come modello aveva un uccello vivo perché, considerata la loro longevità e socievolezza, “un giovane cacatua avrebbe potuto tranquillamente compiere il lungo viaggio fino all’Europa”. Qualche tempo dopo aver pubblicato il suo studio, la Dalton ha ricevuto un’email dallo zoologo finlandese Pekka Niemelä scoprendo che il cacatua di Mantova non era il primo esemplare a essere arrivato in Italia. Alcuni anni prima Niemelä e alcuni suoi colleghi avevano avuto accesso al De Arte venandi cum Avibus custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana notando con grande stupore proprio un cacatua dal ciuffo giallo. Dopo lunghi approfondimenti sulle immagini, gli studiosi finlandesi avevano concluso che era una specie originaria della Nuova Guinea.
Il De Arte venandi cum Avibus della Biblioteca Vaticana non è l’originale scritto da Federico II, ma una copia realizzata dal figlio Manfredi. Nota come Codex Ms. Pal. Lat. 1071, è famosa per le bellissime miniature poste ai margini del testo che illustrano. Quando la Dalton le ha viste ha ipotizzato che fossero rappresentazioni di esemplari di uccelli presenti nei vari castelli di Federico: “poiché Riccardo di Germano, notaio di Federico, riferì che il suo padrone sapeva disegnare, è probabile che l’imperatore stesso abbia avuto una mano nella loro composizione. Sebbene gli uccelli non siano mostrati in scala, le illustrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire, nella maggior parte dei casi, l’identificazione delle specie”. Nel Codex Ms. Pal. Lat. 1071 il cacatua appare quattro volte. In una rappresentazione è accompagnato dalla didascalia “cristas” (creste) con il seguente testo a margine: “La maggior parte degli uccelli con la testa piumata non ha creste. Altri sfoggiano una cresta di piume, tra essi l’upupa, l’allodola cornuta e certi pappagalli importati dall’India. Uno di questi ultimi ci è stato inviato dal Sultano di Babilonia”.
Il nome di Babilonia non si riferisce all’antica città della Mesopotamia, di cui oggi restano le rovine a circa 80 km da Baghdad. Il sultano contemporaneo di Federico II menzionato nel De Arte venandi era il sultano d’Egitto al Malik al Kamil, che certamente risiedeva al Cairo. A poche decine di km esisteva un’antica città chiamata “Babilonia d’Egitto”, ma era una fortezza romana, non correlata alla Babilonia della Mesopotamia. Il termine “sultano di Babilonia” veniva usato in epoca medievale per riferirsi al sultano del Cairo, ma si tratta di due entità storiche diverse. Chiarito l’equivoco, in questa sede ciò che più conta è rimarcare il trattato di pace decennale siglato con al Kamil nel 1229 grazie al quale Federico ottenne la restituzione di Gerusalemme e del Santo Sepolcro alla cristianità. Ne abbiamo parlato nell’articolo “La Battaglia di Gaza” nel numero di marzo del nostro giornale. Ovviamente il dono del cacatua dal ciuffo giallo rientrava negli scambi di omaggi intercorsi tra i due sovrani a latere delle trattative di pace.
Torniamo alla falconeria, dal 2016 dichiarata patrimonio culturale immateriale Unesco. Federico II amava tanto la caccia con il falco da scriverne un libro dal titolo inequivocabile in cui elevò la falconeria ad arte. Lo scopo era quello di mostrare le cose per quello che sono: “Intentio vero nostra est manifestare in hoc libro de venatione avium ea, que sunt, sicut sunt” mostrandosi in ciò un precursore del metodo scientifico.

In Italia la più grande esperta del De Arte venandi è Anna Laura Trombetti Budriesi, professoressa emerita di Storia medievale dell’Università di Bologna, che ne ha curato la edizione in lingua latina e italiana (edita nel 2000, dal Centro Europeo di Studi Normanni). Ecco di seguito ciò che ne scrive nell’Enciclopedia Federiciana: “Il trattato De arte venandi cum Avibus è unanimemente riconosciuto quale una delle opere scientifiche più significative del Medioevo. Il trattato, composto in un limpido latino, si giova dell’uso sapiente di una terminologia, come afferma l’autore, da lui stesso sovente coniata per sopperire ai vuoti di un lessico tecnico ancora in parte da definire: “Quest’arte, infatti, possiede come tutte un proprio lessico; e quando Noi non abbiamo saputo trovare nella lingua latina i termini appropriati ad ogni situazione, ci siamo serviti di quelli che Ci sono sembrati esser più vicini a fare comprendere il nostro pensiero”.
Il 24 maggio scorso a Foggia, al convegno “Bellezza, Conoscenza e Identità. La Capitanata di Federico II” Ortensio Zecchino, professore di Storia del diritto medievale ed ex-Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, ha tenuto una relazione dal titolo “L’arte di cacciare coi falchi tra natura e politica”. Nel suo intervento Zecchino ha sottolineato che Federico, nella Puglia del XIII secolo, si innamorò in modo particolare della Capitanata perché il suo territorio era ricco di alture, boschi, laghetti e acquitrini, l’ambiente ideale per la caccia. In quegli luoghi l’imperatore falconiere trovava il suo svago e nel contempo la pace spirituale. Nel lavoro pedagogico del piegare il falco alla propria volontà c’era il lato metaforico della politica: “il sovrano che domina il falco riesce in qualche modo a far sì che questo animale, per sua natura selvatico, risponda e ubbidisca docilmente in un rapporto di reciproca fiducia. In ciò c’è anche l’idea che i sudditi vadano in qualche modo dominati ma anche assecondati. … La caccia per Federico II era cosa diversa dall’attività cruenta com’era concepita nel Medioevo. Era innanzitutto un’attività intellettuale che richiedeva una partecipazione emotiva. Il che è esattamente la metafora di come il sovrano intendeva governare”.