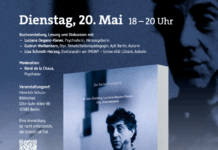Alcune riflessioni sul post pandemia
Nel 2003, quando il fratello maggiore del Covid-19, la SARS, fece la sua comparsa in Asia mi trovavo a Taiwan. Ero appena arrivato, a dire il vero e avevo da poco cominciato le lezioni di lingua cinese. Capivo poco di quello che stava succedendo, ma mi adattai abbastanza in fretta alle norme e agli interventi di urgenza che il Governo Taiwanese dovette adottare. Ripeto, non perché capissi la lingua, ma perché tutte le persone che mi stavano attorno, gli altri studenti, i fedeli alla messa, le persone sull’autobus o al mercato, cominciarono all’improvviso a indossare maschere mediche, a lavarsi le mani con frequenza maggiore, ad aprire le finestre nelle aule e negli spazi chiusi e ad attendere pazientemente in fila per farsi misurare la temperatura ogni volta che si doveva entrare in un edificio pubblico. Da parte mia, lo stupore cedette presto il posto alla routine e poi all’abitudine, tanto che alcune di quelle abitudini, tipo indossare la mascherina di protezione in luoghi pubblici o comunque al minimo accenno di influenza, o come il lavarsi le mani regolarmente, divennero per me così naturali che, quando ritornai in Europa dopo dieci anni, la loro assenza mi provocò un piccolo smarrimento.
Perché questo è quello che successe un po’ in tutta l’Asia. Il virus costrinse le persone a cambiare le loro abitudini, quelle personali, e conseguentemente quelle sociali. E questo fu dovuto al fatto che col virus, vaccino o non vaccino, bisogna imparare a conviverci. E questa convivenza ci richiede di agire sia come individui che come corpo sociale, altrimenti il virus trova il suo terreno ideale, e stiamo provando sulla nostra pelle i danni che può recare.
Ora, partendo dalla mia esperienza asiatica, mi sembra che nelle società occidentali e nei loro sistemi sanitari, si sia persa la capacità di confrontarsi con le malattie infettive, vale a dire, con problemi che si sviluppano in una dimensione collettiva e richiedono la dimensione del bene comune e della coesione sociale per intervenire. In altre parole, i nostri sistemi sanitari, che non sono altro che uno specchio delle nostre società, hanno sviluppato tantissimo la medicina dell’individuo, ma hanno perso terreno nello sviluppare la sanità pubblica.
E certamente, se basiamo i principi educativi e comunicativi relativi al virus sul concetto di “prepariamoci alla terza ondata” come una sorta di ricatto paternalistico fra il governo e la gente, o un meccanismo premio-punizione, allora siamo davvero molto lontani dalla coesione e flessibilità necessarie ad affrontare un cambiamento così minaccioso come una pandemia virale ad alta infettività. E anche se così non fosse, avremmo comunque grossi problemi di comunicazione sociale.
Ma ritorniamo adesso a un concetto che mi sta particolarmente a cuore, ovvero al fatto che in occidente abbiamo sviluppato tanto la medicina dell’individuo, ma allo stesso tempo non abbiamo dato la stessa importanza al concetto di sanità pubblica. In altre parole, le nostre società hanno imparato come allungare la vita mentre invece avremmo dovuto imparare ad allargarla. Allargarla ad altre esperienze e ad altre persone, ad un senso di fratellanza e bene comune che sembra sia stato seppellito da campagne politiche votate ad aizzare paure e diffidenze; allargarla ad altri modelli che non siano quelli basati sulla bellezza e sul successo, che sono quotidianamente proposti da trasmissioni televisive che hanno definitivamente abdicato al loro ruolo educativo.
Certamente, questo non è solo un problema italiano, perché se Roma piange, Berlino non ride. I numeri si stanno alzando in tutti i paesi europei. È tutto l’Occidente che ha fallito, perché ha messo l’economia prima della salute e ora non ha né salute né crescita. Ha, in altre parole, cercato di allungare la vita senza pensare che proprio adesso era il caso di allargarla, allargarla ad altri valori che non fossero quelli proposti dal regime economico che ci controlla. A ben vedere questo problema riguarda tutto quello che definiamo come occidente proprio perché questi sono i frutti di un liberalismo sfrenato, che molti studiosi definiscono come “nuovo”, che si è imposto come ordine regolatore del mondo dopo la scomparsa dei blocchi economici e politici che avevano egemonicamente dominato il mondo a partire dal secondo dopoguerra. Un regime filosofico, prima che socio-economico dove non tutti possono diventare ricchi, solo qualcuno, ma dove tutti aspirano a diventare quel qualcuno. E per diventare quel qualcuno è lecito sgomitare, imbrogliare, corrompere. Non che queste piaghe sociali siano prerogativa del solo liberalismo, esistono infatti in tutti i regimi socio-economici, ma sicuramente vengono accentuati da questa filosofia iper-liberalista che fa apparire la libertà dell’individuo bene unico e supremo, e la sua volontà unico metro di misura e di giudizio delle proprie azioni. Questa è la situazione. E il vero problema è che questa situazione ci ha colpiti in un momento di vuoto politico e sociale che appariva preoccupante ben prima della comparsa del Covid-19. Cosa fare adesso? C’è bisogno di riformare la società, ma credo che la politica non abbia né la forza, né la lungimiranza per poterlo fare. Toccherà a noi, uomini e donne di buona volontà, cercare di far ripartire questo paese facendo in modo, come chiesto più volte da Papa Francesco, di non lasciare nessuno indietro