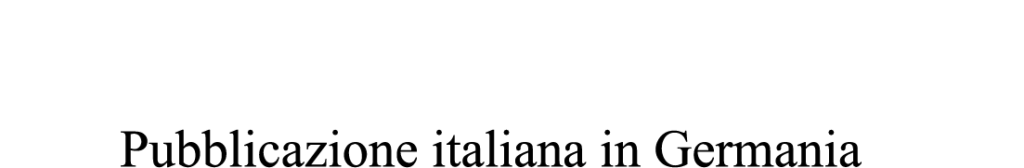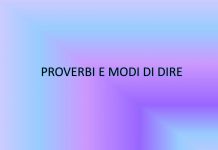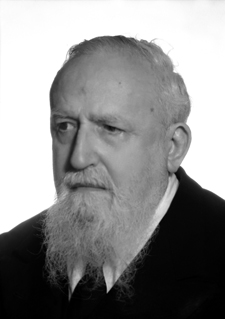Tre storici del ventennio: Gaetano De Sanctis, Giulio Giannelli, Gioacchino Volpe
In tempi come i nostri, sofferti spesso in termini di profonde diseguaglianze e di dolori personali e familiari dovuti al Covid ed alle conseguenti crisi economiche e politiche, non si può richiedere il silenzio consapevole di tutti. Il perdono di gravissimi lutti non è una condotta singolare, né può essere obbligato dalla Società, cui comunque spetta il dovere di garantirlo pur di evitare disordini sociali. Sebbene perdonare, sia pure anche dimenticare, è la Società stessa che richiede una legittima punizione per lo stesso motivo per cui occorre fare memoria,proprio per evitare che covi il risentimento e la vendetta privata.
I filosofi giusnaturalisti si erano espressi già sul tema: Pufendorff già si domandava se lo Stato, sorto dalle ceneri della guerra dei 30 anni, poteva assumere il diritto di favorire la riconciliazione in nome dei parenti delle vittime di un tiranno, specie se questi aveva acquisito con la violenza il Potere e peggio avesse fomentato una guerra ingiusta. Al contrario, i filosofi positivisti del’800, da Sombart a Mommsen, da Ranke a Villari, giudicavano necessario punire coloro che avevano collaborato e perfino plaudito a quelle violenze.
Oggi, a quasi 80 anni dalla fine del Regime più autoritario che ha governato il nostro Paese ed al termine della disgraziata guerra da quello attizzata e pretesa, la scappatoia, tutta mediterranea, di dimenticare le gravi violenze avvenute nello stato liberale nel primo dopoguerra, la tirannia ideologica e politica fra il 1922 ed il 1943; il ritorno delle violenze durante la 2° guerra Mondiale e la riconosciuta Resistenza popolare al Nazifascismo; la ineludibile volontà popolare antifascista presente nella Costituzione Repubblicana è la storia del Paese negli 80 anni successivi; spesso infiorata da stragi che la giurisprudenza passata in giudicato ha attribuito al terrorismo neofascista; sono state circostanze che non si possono dimenticare.
In fondo, uno degli scopi della storia è quello di fare memoria per impedire che fatti esecrati contro la società civile possano ripetersi e di conferile quindi il Potere di punire coloro che lo tentassero. Una mano ai giudici però deve essere data agli Storici per evitare rotture della coesione sociale, troppe volte minacciata da amnesie causate da un senso di stanchezza ripetitiva, o da forme di anestesia dovute ad ignoranza o da superficiali letture della Storia, confusa da interpretazioni della politica del presente che prova a disinteressare lo studio della storia delle nuove generazioni. Esaminiamo dunque la condotta di alcuni storici che nel primo dopoguerra reagirono alla prova di forzare la democrazia liberale faticosamente raggiunta nel Risorgimento.
Nel triennio successivo alla fine della Grande Guerra – 1919/1922 – è noto che le tensioni sociali nel nostro Paese – ma anche in buona parte dell’Europa scossa da quell’evento – erano all’apice: i Quatto cavalieri dell’apocalisse di medievale memoria lo avevano attraversato in lungo ed in largo fin dallo scoccare del secondo decennio del ‚900. Epidemie e malattie primeggiavano dalla pianura padana alla Sicilia, dove ancora circolavano malaria, tifo e podagra che rendevano difficile l’economia agricola rimasta la prima industria della Nazione.
Povertà, carestie, disordini sociali, mancati accordi sindacali, una costante refrattarietà del mondo contadino cattolico alla partecipazione politica, avevano indotto le élite liberali ad adottare provvedimenti repressivi e troppo lentamente cresceva un maggiore dialogo era le forze popolari socialiste e cattoliche, accompagnato da un rilevantissimo sviluppo della economia industriale promosso da capitali esteri – spesso di fonte germanica – che nel primo decennio del secolo produsse un moderato sviluppo del Paese, benché l’indice di emigrazione all’estero e l’inflazione nel 1906 produssero non poche difficoltà all’economia meridionale, il cui sviluppo subiva non pochi rallentamenti da guerre che il governo dell’epoca privilegiava per ottenere un maggiore consenso dalle élite culturali ed una certa speranza di ripresa fra le classi popolari.
La guerra di Libia (1911) e la Grande Guerra (1915) rappresentavano iniziali circostanze che generarono aspettative di miglioramento dopo più di 60 anni di Unità nazionale. Non era ancora foriera di un benessere migliore rispetto all’800 in cui convivevano non pochi ceti sociali in conflitto far loro. Prendiamo allora un primo storico, l’antichista Giulio Giannelli, classe 1889, grecista ed ufficiale addetto alla censura dal 1915, significativo per l’adesione totale al Governo conservatore e nell’animo un guerrafondaio. Collaboratore di storia antica all’Università cattolica di Milano, succedette cola a Luteno.
De Sanctis nel 1923, quando quel cattedratico già aveva rotto col Regime Fascista e col Gentile. In quei primi anni di simpatie crociane e nazionaliste, Giannelli collaborò fra il legame con Cornelio Di Marzio, storico del diritto romano, segretario della Confederazione fascista dei professionisti intellettuali e degli artisti, che lo rimproverò di aver avuto simpatia per l’omosessualità di Alessandro Magno (voce dell’enciclopedia italiana diretta dal Gentile), ed il rispetto dei canoni del Croce, che aveva dato allo storico la patina di essere anche un’artista che vive i fatti della storia.
Quando scoppia il caso De Sanctis, che nel 1931 rifiuterà di giurare fedeltà al Regime ed allo stesso Gentile. Coerente con il suo pensiero non mancherà invece di giurare e dal 1933 fino al 1964 guiderà la cattedra di Storia Greca e Romana nella città di origine fino alla morte. Materia classica che Giannelli curò in modo sistematico ed in modo massiccio quanto ondivago, senza alcun chiaro riferimento alla attualità e con qualche sporadico accenno critico, come se volesse coscientemente dimenticare o tacere sugli eventi fiorentini del primo dopoguerra: per esempio, il 7.11.1920, a Firenze è ucciso a colpi di pistola il giovane Guido Fiorini ed una bomba sfracella lo studente Guido Bolaffio; ed il 10.12 successivo una squadraccia fascista guidata dai futuri Parlamentari Italo Capanni e Manfredo Chiostri, massacrava in provincia l’anziano sindacalista agrario e socialista Giovanni Sitrialli per vendetta dei primi due omicidi.
Dov’era il Giannelli, dopo essersi espresso sul suo Manuale di storia greca, sul principio classico che la storia è la maestra di Vita e che la Vita è altrettanto maestra di Storia? Reciprocità di critica e di vita che non poteva essere senza memoria, proprio perché il Diritto prevede una punizione esemplare per monitorare e prevenire quella vendetta personale che Giambattista Vico ed Ugo Foscolo indicarono come il segno indelebile di una coesione sociale che va a decadere. Del resto, la scelta democristiana e comunista di perdonare gli eccessi fascisti, ivi compresi le vicende della Resistenza immortalati da nel famoso film Cronache di poveri amanti del 1954, tratto da un romanzo di Pratolini e diretto da Carlo Lizzani; non esime lo Storico dal dimenticare, senza però eccedere nella violenza, a chi ha fatto del male. Infatti il Bayle, Principe degli storici moderni, che nel suo Dizionario storico (1695), insistette sulla neutralità di chi espone fatti storici senza pendere da nessuna delle parti. Ed il suo silenzio di Gaetano De Sanctis pesa ancora. Quindi come senatore e pedagogo la sua figura si staglia nella Memoria come un un educatore nella coscienza critica attuale.
La recente pubblicazione dei suoi Ricordi della mia vita – ed. Tored 2024 – rivela una personalità tutta di un pezzo, perché molti ne danno un valore civile appassionato, fuori dalla flemma ordinaria ed accomodante del collega Giannelli. Sturziano, chiaramente critico del Fascismo, non solo si rifiutò di prestare giuramento con 11 colleggi al Regime nel 1931; ma accettò così di rinunziare a carriera e cattedra. Soffrì di per sé anche per la perdita progressiva della vista, ma la storia del mondo greco e romano – condiviso col più fortunato Trattato del 1948 di storia romana del Giannelli, è caratterizzata già nel titolo, Storia dei Romani del 1953 – trovò una nugolo di allievi che perpetuò già nel 2007 il ricordo, quando i suoi discorsi parlamentari da senatore a vita della Repubblica non solo ricostruiscono le ferite inferte alla democrazia liberale risorgimentale, ma anche risultando pensiero favorevole all’Europeismo di De Gaspari ed Adenauer. Una riconciliazione che non dimentica dunque, ma che porta anche a riscoprire i mali che generarono la caduta dello Stato risorgimentale e che potrebbero ricomparire anche oggi per inerzia dalla società civile. Ma De Sanctis seppe anche individuare le pecche di storici di Regime, come lo fu Gioacchino Volpe, aquilano, che insegnò storia moderna a Milano e Roma.
Imbevuto di Nazionalismo ed ispirato dalla scuola Tedesca Pangermanista, concede al Medio Evo una natura positiva perché lo considerò un’età fervida per lo sviluppo demografico ed economico già dopo l’anno 1000. Ribaltò i giudizi negativi di Villari, Salvemini e Croce, sull’Italia di Machiavelli e Gucciardini. Diede a Dante la qualifica di uomo di destra, recentemente ripresa dall’attuale Ministro della Cultura. Rivalutò pure l’opera del Crispi, negò il liberalismo politico, difese e promosse la cd. Rivoluzione Fascista, fino al 1960 addirittura osò rimpiangere il secolo XV che sicuramente aveva avuto un momento della migliore Italia dopo Roma. Unilateralismo di giudizi che lo pone a capo della corrente revisionista storica del ‚900 italiana, non privo di mende memorialiste, ma che ci consentono di riaprire le porte chiuse dall’altrettanta parzialità di non pochi storici di sinistra che hanno mantenuto aperte ad arte le ferite della Storia. Traumi che abbiamo qui appena cennati e che i tre storici hanno tentato a loro modo di sanare adoperando l’arma del lunghissimo tempo trascorso dagli eventi contestati. Del resto, una società che non riesce a fare memoria obiettiva del suo passato è prossima purtroppo alla sua estinzione.