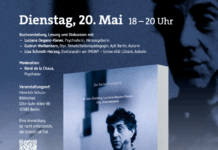Al ritorno dal viaggio in Italia a Weimar (aprile 1788), nel suo secondo periodo della corte weimeriana, Goethe iniziò l’amicizia collaborativa col giovane Schiller, un po’ troppo austero, ma col quale instaurerà un dialogo proficuo che lo arricchirà intellettualmente, fatto che costituirà l’aspetto fra i più famosi sia della sua vita che del pensiero, ormai biograficamente arcinoto, ma che ci sembra sufficiente per delineare quella effettiva età dell’oro che la corte di Weimar visse nella persona dei due dioscuri della Germania, alla cui Corte culturale parteciparono anche Wieland, Herder e Klopstock, una scala reale di letterati pari a quella che vi fu ad Atene e a Firenze. Un ventennio, (1788-1808), dove Goethe produsse il massimo del suo pensiero e delle sue opere: quanto al pensiero, riaprì il classicismo al suo più alto livellò, ribaltando il senso di rassegnazione al reale in un senso di magnanimità verso l’altro e in una superiorità morale ed estetica che gli derivò dalla collaborazione con Schiller, la sua nuova coscienza critica che gli permise quel ritorno all’essere vivo nella Natura.
Questa gli fu limite, fonte di gioia e di quotidiana accettazione. Nacque ora in lui un pensiero politico mai esplicato: prima accettò la Rivoluzione Francese in senso riformista; poi si convinse che le monarchie assolutiste dovevano riformare leggi e relazioni sociali per dare spazio alla borghesia produttiva; quindi, plaudì alla vittoria di Valmy nella misura in cui il processo iniziale si potesse orientare in tal senso di fronte alla reazione delle classi nobiliari ormai fuori dal tempo.
Ma quando la nuova Repubblica favorì le masse popolari rabbiose e diventò il motivo del Terrore che seminava morte senza ragione; e quando vide che quelle riforme altro non erano che stragi senza sosta, lo stesso terrore all’opposto lo prese e lo portò a proclamare il ritorno all’ordine. Fu la svolta della maturità. Incontrò Napoleone e lo ossequiò più volte, credendo a Lui come il nuovo mondo e il nuovo Padre politico della futura letteratura mondiale. La reazione romantica nazionalista lo atterrì ancora di più perché evocava quella conservazione politica che aveva già stigmatizzato, quel Medio Evo cristiano oscuro che abbagliava Kant, Beethoven e Fichte, quel piacere della follia che eccitava Kleist, che illudeva perfino Schiller. Passaggi che gli fanno scrivere operette non secondarie – “‘Ermanno e Dorotea” (1797); “Il grande Copto” (1791), “La figlia naturale” (1802).
Drammi e idilli che nel tentativo di svilire le presunte novità rivoluzionarie, mostravano, con potenti metafore classicheggianti, il suo rifiuto per la violenza e proclamavano comunque l’ascesa delle classi inferiori, piuttosto che un terremoto che lasciava dietro di sé rovine e lutti. Da buon illuminista spinoziano, auspicava invece un lento, ma inesorabile cammino naturale, la cui forzatura da mano dell’uomo altro non produceva che altri disastri, come era avvenuto dopo Napoleone. Goethe, all’annunzio della presa della Bastiglia nel 1789, come Kant ne fu sorpreso e ne fu contento, mentre il cortigiano Wieland, mai in buoni rapporti con Goethe, da buon illuminista della cattedra, plaudì all’evento rivoluzionario come prodromo della rinascita della Germania come nazione unitaria. Già a settembre del 1789 – in pieno periodo di “Grande paura”, secondo la periodizzazione dello storico Michelet – Goethe si metterà in viaggio di riposo in Sassonia, quando a Dicembre incontrerà Wilhelm von Humboldt, un caro amico che lo seguirà fino alla morte nel 1832. Infine gli nascerà il figlio maggiore Augusto.
Per diversi anni tace sulla Rivoluzione. Unica bozza d’opera, peraltro giudicata forse con superficialità,“minore”, fu la tragedia “Tasso”. Poi a poco a poco cominciò a parlarne agli amici. Nel 1790 scrive al filosofo Jacobi: “I grandi scrittori sono al capezzale della Francia, che cadde con loro!” Il riferimento ai tanti illuministi e poeti, come Condorcet e Chenier, appare evidente. E poi nel 1795, romperà definitamente il silenzio. Ora scriverà il romanzo, denso di dialoghi, “Conversazioni di emigrati tedeschi” (1795), dove già enunziava la sua tesi: “al dispotismo del Re era seguita la tirannia del popolo”. Anzi, al danno si era aggiunto la beffa: a conti fatti e vista la strage operata sui parenti degli emigrati in Germania, il danno che la Francia aveva arrecato a se stessa per Goethe era divenuto irreversibile.
Anzi, il terrore francese aveva generato il nazionalismo borghese tedesco, minacciato dalla vittoria di Valmy e dunque la catastrofica rottura ideologica e morale fra le due rive del Reno. Nondimeno, questa valutazione fu profetica: basti pensare che dalla guerra franco/prussiana, alla seconda guerra mondiale, fino alle punzecchiature fra De Gaulle e Adenauer, prima della imprevista soluzione europea del 1958, furono emergenze giustificate proprio dalle ultime linee di pensiero di Goethe, che confluiranno nella teoria della Letteratura Universale, più volte rilanciata tra il 1829 e il 1832.
Una sua prima linea di pensiero fu il ritorno al Classico, inaugurato proprio col citato “Tasso”, ma poi ribadita con un poemetto, “l’Ermanno e Dorotea” del 1798, piccolo idillio epico in nove canti, ciascuno recante il nome di una musa, che 80 anni dopo avrà in Carducci un ottimo traduttore. Perché Goethe scelse una storia d’amore, popolare sulle rive del Reno, piena di forme armoniose, espressioni dolcissime di costanti riferimenti all’età dell’oro omerica? La risposta è evidente: il suo animo pacifista, il suo favore per l’assolutismo illuminato, ma anche per i poveri contadini, prima vessati da nobili ingordi, poi maltrattati dalle orde napoleoniche. Infine, la speranza dell’Imperatore con cui ebbe alcuni personali colloqui, che però non ebbero alcun risultato positivo, riluttante per superbia a riportare finalmente l’ordine naturale delle cose.
Erano queste le circostanze che motivavano la sua ansia di pace mondiale. Proprio nel decennio prima della morte non cessavano le sue interminabili discussioni fra Classicismo e Romanticismo, in particolare coi giovani scrittori e critici di Berlino e di Iena, specialmente l’accusa di essere stato un freddo calcolatore, di aver plaudito al nuovo tiranno che aveva riconfermato la divisione della Germania, di aver ricreato una classe dirigente filistea, borghese e meschina; di essere rimasto a galla, o peggio estraneo ai moniti di Fichte contro l’invasione francese, in una parola l’avere ritrattato lo “Sturm un Drang”, abbandonando il titanismo che lo aveva visto anticipare a più di 10 anni la caduta della Bastiglia, per poi rifugiarsi nel placido mondo borghese di Weimar. Scelte che Heine, Novalis e Buchner gli rinfacciarono nei primi anni del ‘800. Perfino il “Viaggio in Italia” gli fu contestato. Altro che rinascita culturale dopo la vita di Corte: lo si vedeva come un pasciuto borghese tranquillo dal verso estetico elevato, senza alcun senso politico di classe, disimpegnato nel secolo, incosciente del dramma della nazione occupata dello straniero. Due erano le accuse più forti: cosmopolitismo e reazionismo.
Alla prime accusa – che già i fratelli Schlegel e perfino il giovane Hegel gli avevano opposto dopo le sue conversazioni con Napoleone – ecco, allora “l’Ermanno e Dorotea”, senza dire del “Tasso”, la cui eziologia possiamo riassumere nella “nevrosi del gentiluomo di Corte”, che Goethe tentò di superare proprio col viaggio in Italia. Nondimeno, la trama appare di una novità assoluta, costituendo un primo esempio di romanzo popolare, sia pure in forma classica. Infatti, si narrava di una ricca ragazza di Salisburgo che, in nome della sua fede luterana, aveva abbandonato famiglia e patria. Novella Abramo, si mise in marcia seguendo la voce di Dio e si sarebbe fermata nel paesetto di Öttingen in Franconia. Colà incontrò Ermanno, ricco contadino. I due cominciarono a parlare e a fare amicizia. Dorotea era una strana ragazza, colta e riservata, ma pensierosa e lontana dai circoli cattolici della città. Il giovane le propose di fare la governante presso il padre ormai vedovo e anziano. Dorotea accettò e seguono pagine di poesia arcadica dove il giovane descrive i lavori campestri di cui lui era esperto.
Qualche settimana dopo, il giovane, ormai innamorato, chiese al padre di poterla sposare, non senza avere prima raccolto informazioni positive dagli altri esuli luterani. Il padre, cattolico fervente, dopo vari tentennamenti e dopo aver quasi minacciato il figlio di diseredazione se la avesse sposata; viste le resistenze del figlio, finì per acconsentire. Interessante il finale: la serva non pensava che il giovanetto avesse manovrato col padre per il matrimonio, e quando, il padre le chiese se le piacesse il figlio, fiutò il tentativo di una tresca. La sua onestà fece il resto: rifiutò l’affronto e fece per uscire. Il padre capì così la straordinaria dirittura morale e parlò subito di matrimonio. Dorotea, confusa per l’equivoco, palesò i suoi beni e in modo inusitato offrì 200 ducati per dote. Il matrimonio è fatto e tutti vivranno felici e contenti. Siamo ben lontani dalla tragedia di Schiller “Luisa Miller”, finita con il suicidio della protagonista, in stile preromantico. Siamo più vicini alla “Serva padrona“ di Paisiello già in pieno illuminismo (1733). E poi Goethe con rara maestria equipara gli esuli protestanti agli esuli francesi e ricrea una storia d’amore quotidiana simile alle trame del suo amato Mozart.
Inoltre, mirabile è la battuta quasi finale:”Signore come sono incomprensibili e tuoi giudizi, come sono ignote le tue vie!” Non era una preghiera. ma una considerazione di speranza e di fede, dove Dio sta nel quotidiano e non si fa come nei romantici che si tormentano per cercarLo sempre altrove. Certamente, qui Goethe rivede radicalmente le conclusioni del “Werther”, prestando il fianco alle critiche romantiche che lo vedevano un obsoleto poeta classico, incapace di passione politica, forse un ottimo spirito illuminista, che aveva nostalgia dell’età classica. In fondo, Byron in Inghilterra, Foscolo in Italia, Hölderlin in Germania, avevano passato lo stesso guado e avevano attraversato con un barca classica il fiume rosso del Terrore, negando la necessità di aspettare che finalmente la Natura facesse il suo corso.
Il terrore invece correva e abbatteva, bruciava il vecchio e ammirava un nuovo che non arrivava mai…. La realtà dei fatti aveva infranto la rete idilliaca di molti geni, ivi compreso l’amico Schiller che con la “Maria Stuarda” aveva ripreso la via del sacrificio e del dolore, che fece di quella regina l’emblema del nuovo secolo. Goethe, che non era più un temperamento rivoluzionario, ma che aveva scatenato la passioni di molti giovani europei affascinati dal suo giovanile ribellismo, senza un’idea irrazionale di cieco furore panico delle masse e dunque, da buon scienziato delle cose naturali, dopo aver meditato le vie praticate da Vico quasi un secolo prima, che aveva meditato da classico la Ragione Cartesiana; si pose a contenere ai fianchi il mostro che avanzava, leggendo fra le pieghe le macchie di quel Terrore.
Operazione che un secolo dopo riproporrà Thomas Mann di fronte alla democrazia caotica della Repubblica di Weimar. Con le sue analisi dal basso, per esempio sulla figura del gran cofto (Cagliostro), coglieva i difetti della democrazia, ma con la tragedia “Der Bürgergeneral” (1793) attaccò senza limiti il nazionalismo prussiano.
Distaccatosi progressivamente dai romantici Schlegel e Fichte e silenzioso nelle varie guerre napoleoniche sul suolo tedesco; Goethe ritornò all’isolamento per quel suo apparente favore per l’invasione. Scrisse le “Elegie romane” (1789); “Gli Epigrammi veneziani” (1790); riprese il “Faust”, configurandolo in senso più classico rispetto all’Urfaust titanico del periodo giovanile. Versificò di nuovo la “Ifigenia” e finalmente la ripropose in prosa, mantenendo lo stile classico in generale. Pure per il “Tasso”, dove l’umanesimo magnanimo e visibile di un Ariosto stemperava la passionalità dello stesso Torquato. Ma l’opera che lo rilancerà ancora, quale giusto mezzo fra gli eroici furori del “Werther” e la placida contemplazione del bello della vita, non separata da una visione ormai pacata, è la riproposiziona del romanzo di “Wilhelm Meister”, cioè di se stesso, negli anni di “apprendistato” (1796), non più nel teatro, ma nella realtà esistenziale del viaggio di un’anima nel mondo. Infine, l’ulteriore cambio di passo nella poesia e nel messaggio: la ballata “L’apprendista stregone” (1797), quasi uno scherzo, un profetico apologo sulla tragica avventura scientifica dell’uomo, che si lascia distrarre dalla sete di onnipotenza sulla natura e sulla fatica opera di salvezza del suo sé quando la natura vien molestata.
Il successivo salto di qualità fu però coincidente con la citata intesa con Schiller. Tale collaborazione (presente in tre momenti: le “Xenie”, i “Propyleis” e le “Horen”, riviste letterarie di comune redazione, che a Weimar pubblicavano critiche e opere letterarie di spirito neoclassico, in contrapposizione alle riviste romantiche di Jena e Berlino), riguardava due obiettivi: mediare le idealità estetiche e i condizionamenti di una società ormai dominata dal Capitale e respingere l’opposto estremismo terroristico, instaurando una cultura delle responsabilità che ponesse la letteratura a indirizzare la politica verso il vero, il giusto e l’utile sociale. Un programma d’azione che i due formularono nel saggio “Poesia epica e poesia drammatica”(1797).
La morte di Schiller (1805), improvvisa e dolorosa per il Vate, chiudeva però questa fase, ma il suo viaggio non era affatto concluso. A 57 anni Goethe ritornava a soffrire, pur con minore angoscia, di solitudine, aggravata dalla morte di Schiller, Herder (1803) e Wieland (1813). Nondimeno il suo pur passeggero interesse per Napoleone, costituì la sua esclusione dalla politica di Corte, visto che l’altro grande amico – il granduca Karl August, ormai ritornato regnante dopo la pace di Basilea con Napoleone – dovette accettare il protettorato dell’Impero francese, avendo così l’ottima scusa di estraniarlo dal governo. Non gli rimase che la pensione dorata di uomo di stato, le entrate dei proventi letterari e dagli affari che la moglie gli aveva procurato – una servetta intelligente, Christiane Vulpius, che nel 1806 lo aveva finalmente sposato, dandogli un figlio maschio un po’ imbecille, Augusto, per cotanto Padre… E l’ultima amica, la Baronessa Charlotte, ormai anziana, che però non cessava di consolarlo. E’ il periodo della vecchiaia, anni di memorie e di rielaborazioni. Qui un’altra svolta di vita.
Dal 1808 al 1832, anno della morte, il Faust era sempre in gestazione, in una altalena fra classico e moderno, fra antico e gotico, quasi una nuova “Divina Commedia”, come il vecchio Goethe adombrò nel 1831, a commento della sua finale pubblicazione. E poi un dramma politico, “Pandora“, ancora sulla rivoluzione francese (1808), due romanzi, “Le affinità elettive” (1809) e “Gli anni di peregrinazione di Wilhelm Meister” (1829), ennesima ricostruzione ormai romantica di se stesso, stavolta nella fase di rassegnazione. Introdusse nella narrazione dei racconti che spiegavano le sue rinunzie e dove
emergevano momenti di spontaneità e di sincerità sulla sua vita isolata e decadente, di cui però non era affatto rammaricato, anzi ne era consapevole, visto che non cessava di amare, ma non poteva essere più riamato. Proprio nel racconto, “L’uomo di 50 anni” (1817) e nella lirica “L’elegia di Marienbad” (1823) narrava di se stesso innamorato di una giovane diciassettenne e nostalgicamente rievocava la passata giovinezza . Ma a 70 anni, nel 1819, ha una fulminea decisione: riprendere la poesia orientale che aveva studiato ventenne a Strasburgo, con gli amici ormai morti, Bürger e Lenz. Una serie di veloci “Gazhel”, a rime assortite e brevi, che il poeta iraniano Hafis aveva cantato all’epoca delle Mille e una notte alla fine del primo millennio.
Fra il 1814 e il 1819, uscì una sua raccolta di poesie, erotiche e religiose, “Il divano occidentale e orientale”, in origine una rassegna di figure universali a prevalenza mediterranea, con amori efebici e nature strane, degne di un esteta non lontano da Oscar Wilde, che a fine ottocento le ripropose, ricreando un mare di critiche. Non poteva non mancare l’autobiografia “Della mia mia vita, poesia e verità”, due edizioni, 1814 e 1830, dedicate alla sua vita di scapigliato oppositore dell’allora sentire sociale, proprio per giustificare le sue simpatie conservatrici e antiromantiche contro le scuole impregnate di nazionalismo, che non gli perdonavano le simpatie napoleoniche e che lo misero quasi alla berlina chiamandolo “Onnipotente” e “Olimpico”, aggettivi che saranno ripetuti per buona parte dell’ottocento, situazione aggravata da vari tentativi di ripubblicare sotto falso nome non poche sue opere poco conosciute. Eppure, tanti scrittori tedeschi, italiani, francesi, inglesi, russi e americani le traducevano nella loro lingua, gli scrivevano, lo visitavano nella sua vecchia casa di Weimar, più un museo di anticaglie e sede dell’ultima sua rivista “Kunst und Altertum”, centro nevralgico antiromantico e bandiera del Classicismo mondiale. Erano gli anni dei carteggi con Hugo, Carlyle, Puškin e Byron, con Heredia e Manzoni.
Finalmente terminò il suo “Faust”, miscelando con prodigiosa continuità classico e moderno, rendendolo eterno. Ed è di questo lungo periodo, di cui dire “fecondo” non ci pare affatto limitativo, la saggistica. Se si volesse capire perché fu così avverso alla Rivoluzione Francese e poi al Romanticismo, ma solo a quello tedesco, si dovrebbero esaminare i tre saggi su Shakespeare (1815 – 1816) e poi il citato saggio con Schiller, apparsi proprio sulla rivista “Kunst und Altertum”. Per i rapporti con l’Italia, valgono i suoi scritti su Goldoni – per esempio, il commento sulle “Baruffe chiozzotte”, presente nel “Viaggio in Italia”. Oppure i rapporti con Manzoni nelle varie lettere e nella pregevole traduzione elogiativa del “5 Maggio”, senza contare il controverso parere di Goethe sulle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” del Foscolo, fino alle critiche positive sul Monti e l’Alfieri.
Le epoche letterarie successive ne fecero un idealista (Hesse); uno scienziato (Darwin); un mistico (Steiner); un individualista borghese (Lenin). Il giudizio di Nietzsche lo fece uscire dal dimenticatoio. Mann lo pose in antitesi al nazismo e padre della Germania europea e non più di una Germania onnipotente ed autoritaria. Poi non sono mancati giudizi singolari, come quello di Freschi e di Rovelli, che hanno rilevato come nelle sue opere permanesse l’idea di una sovrapposizione fra il fenomeno scientifico da osservare e l’idea innata dell’osservatore. Per noi fu soltanto un Classico, perché i suoi valori di riferimento rimangono intatti all’usura del tempo.