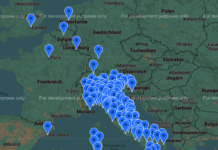L’attuale riaccendersi delle polemiche antitedesche in occasione della crisi epidemiale del corona virus e delle ricadute rischiosissime sulle economie europee a regia tedesca; riapre la polemica delle polemiche che ha attraversato la storia del continente per almeno tre secoli, dalla fine della guerra dei trent’anni (1658) fino al 2008, quando la crisi del debito sovrano assestò un colpo di maglio non indifferente al sistema politico economico dell’Unione Europea. Benedetto Croce affermò profeticamente che non esiste una storia antica o moderna, ma che tutta la storia è sempre contemporanea, il suo messaggio guardava al contesto analogo di quei tre secoli, tutti attraversati da una trasformazione epocale, il passaggio incessante da un’economia rurale di mero consumo a un’economia industriale di massa.
A tenere unita la cultura dei tanti popoli insediati dal Tago all’Elba, dal Po alla Loira, dal Volga al Danubio, non basterà più una cultura legata alla terra, quanto e piuttosto allo scambio e al prodotto, in cui il fulcro è l’uomo, materiale e spirituale ad un tempo. A fare dell’uomo l’essere per tutte le stagioni, dalla culla alla tomba, emulo del Dio fatto uomo, custode della natura, ma anche suo dominatore e sfruttatore; sarà però il mito, la narrazione eroica dell’uomo nella lotta per la sopravvivenza e la malinconia per il progressivo suo decadere. Tutta la storia potrebbe riassumersi in un duello fra chi la legge come progresso o come regresso, fra fautori della scienza e della tecnica che lo distaccano da paure e malattie, epidemie sconosciute che vengono sconfitte; e difensori dello Spirito, dell’idea del Vero, del Bene e del Buono alla cui ricerca nostalgica ci si pone pensando al tempo dell’oro, o al paradiso perduto, al comunismo senza classe, al libero mercato senza vincoli, ecc. ecc. In fondo, ogni polemica culturale è polemica col materiale, ogni conflitto ideologico è figlio antinomico fra ottimisti delle volontà e pessimisti cronici. A mediare ritroviamo i pessimisti storici, oppure i ricercatori dello Spirito che mettono la speranza di tempi migliori in prima linea, magari rileggendo filologicamente i grandi narratori del passato, scoprendone le ragioni di vita, il loro vedere il mito come strumento per superare le asprezze della vita quotidiana. Ecco perché il mito si fa storia e la storia dovrebbe risalire al mito per capirne il fine e le cause. E siccome miti e storie hanno avuto la loro sede naturale – ma non l’unica, come si sottolinearono illustri storici dell’ultimo secolo – nella scrittura, ecco il nascere fin dal secolo dei lumi di una scienza esatta, la filologia. Anche qui, lo sviluppo culturale ha imposto l’adozione del metodo analitico del testo. Maestri della ricerca del mito nella letteratura ne conosciamo tanti fin dall’umanesimo italiano – Dante, Petrarca, Boccaccio, Marsilio Ficino tanto per citare i più noti – e maestri analoghi in Germania furono i padri della letteratura tedesca, Lessing, Herder, Klopstock, Goethe, Schiller e Hölderlin, classici e romantici, cioè umanisti e scienziati dell’interpretazione, storici con la riga e il compasso, rivelatori dello spirito e delle situazioni materiali della loro epoca. Poi vennero i positivisti che fecero della filologia scienza, di prevalenza tedeschi, che approfondirono e ordinarono le fonti facendone la scienza dell’idealità concreta, come aveva prefigurato l’Hegel, che aveva dimostrato la validità e il senso delle antiche testimonianze, rilevando il nesso delle manifestazioni singole con le maniere collettive di pensare e di intuire dell’antichità. Il re di tale scienza a metà ‘800 fu Ulrich Wilamowitz von Moellendorff, campione dello storicismo filologico e suo principale erede lo storico Theodor Mommsen, premio Nobel per la letteratura nel 1900. La vittoria dell’evangelismo materialista, soggettivista e antispiritualista, mitologicamente critico e portatore del progresso scientifico elevò la classe intellettuale tedesca sul piano europeo e mondiale, fedelmente alleata al liberismo economico e al nichilismo religioso, al più relegato a forme deiste di devozionalità. Ma una polemica apparentemente secondaria, nata proprio fra le carte redatte da un grecista oggi sconosciuto, mise in discussione la fede avventatamente posta sui miracoli della tecnica dell’epoca, dove la vittoria sulle paure dell’uomo non aveva più la veste della riscoperte del mito, ma la forma di un semplice algoritmo.
Tolstoj, Nietzsche e un dimenticato filologo, pentito del metodo analitico classico, Ettore Romagnoli, misero in difficoltà non solo il metodo, ma anche la sostanza del metodo. Tolstoj, mise presto in luce come il sillogismo di Aristotele non spiegava né la vita né la morte; Nietzsche risalì allo spirito dionisiaco per interpretare Eschilo; Romagnoli rilesse Aristofane e il suo spirito ironico per rompere l’acribia meticolosa della classe intellettuale tedesca. Nel suo controverso volume – “Minerva e lo scimmione” del 1917 – Romagnoli identificava nella filologia tedesca la pretesa di abbracciare mortalmente la natura del mito classico, che non poteva resistere alla maliziosa profferta. Ma andiamo con ordine: la carriera di Ettore Romagnoli in campo filologico, aveva avuto una certa notorietà traducendo, da docente universitario a Catania nel 1905, i tragediografi greci, ritrovando nelle aree geografiche della Sicilia sudorientale lo spirito ispiratore dei suoi studi classici. Fulminato dal pensiero di Nietzsche sulla nascita della tragedia, che lo indirizzò a interrompere il filo germanistico apollineo che aveva investito i dioscuri Wilamowitz von Moellendorff e Mommsen, riscoprendo direttamente i miti e le fantasie liriche (1910); i drammi satireschi di Euripide (1911) e il “grottesco” della tragedia greca (1926). I suoi libretti di traduzione cominciarono a circolare sugli spalti del Teatro Greco di Siracusa e ad essere colà recitati fin dal 1914, senza contare i suoi commenti musicali alle tragedie stesse, opera originalissima che lo pone come un eccezionale scopritore della musica greco-romana, tema che meriterebbe un articolo a parte. Epperò, la storia della filologia classica del ‘900 lo vede protagonista di una singolare disputa antifilologica germanica che lo ha relegato ai margini della cultura europea, ritenuta dozzinale dal Contini e superflua dal Canfora. Forse perché noi siamo siracusani a Lui riconoscenti per aver valorizzato il teatro greco, e sopratutto per aver ritrovato nella sua polemica un valoroso modello di rinascita dello Spirito sulla storia, ancella dello filologia matematica demitizzata e ridotta a un mero esercizio oggi diremo di copia e incolla, cioè di eccessiva frammentazione del verso, perfino della sillaba, per non parlare della grafia.
Nelle due edizioni del pamphlet “La Minerva e lo scimmione” del 1917 e del 1919, la verve espositiva del Romagnoli esplodeva quasi in un sarcastico e godibilissimo J’accuse degno di un Eschine o di un Cicerone, denso di un humour italico che di per sé lo mise in evidenza negli anni del dopoguerra, prima fra gli interventisti, poi fra i futuristi e che infine ebbe nel Fascismo la sua apoteosi. Criticato dai crociani e dagli antifascisti per il suo nazionalismo e per aver cavalcato contro la cultura mitteleuropea; ostracizzato dalle sinistre nel secondo dopoguerra per il suo linguaggio aulico e cattedratico, forse troppo dannunziano e certamente carico di espressioni classiche che non certamente in linea con le nuove ideologie popolari post-fasciste; amato contraddittoriamente da Vittorini per la questione delle origini della tragedia; Romagnoli è ritornato nelle pagine di stampa tedesche – ironia della storia! – per le sue scoperte scientifiche nel caso della musica antica. Prova ne è stata di recente la mostra organizzata a Würzburg, preso il museo universitario “Martin von Wagner” sulla musica greco- romana, che lo ha visto fra gli autori moderni più popolari per la singolare ricostruzione degli antichi ritmi del Mito. Ma come si è detto, la polemica antitedesca del Romagnoli – legata peraltro a questioni di lotta di potere accademico fra baroni universitari – ebbe nel Pohlenz, altro notissimo esegeta tedesco, un forte oppositore. Pur aderendo alla critica di eccessiva erudizione della scuola filologica germanica, che spesso debordava a un meccanicismo grafologico deviante e puramente formale; il filologo tedesco però ribatteva a favore della scuola filologica tedesca che la pretesa estetica magnificata dal Romagnoli non era stata obliterata a svantaggio del piacere spirituale dell’opera d’arte, a cui è inopportuno avvicinarsi se non in modo completo, dove parola scritta e pensiero vanno insieme, cioè rifacendo passo dopo passo l’idioma dell’autore e dei lettori. La filologia classica era non una semplice ancella della storia, quanto il suo specchio, onde tutta la filologia altro non era che l’altra faccia della stessa medaglia della storia dell’uomo.
Per Pohlenz esiste un’unità complessa dello spirito umano che spiega la civiltà di un popolo fin dalle sue origini mitologiche. Ed è questa la via seguita dai cultori del Mito nella storia attuale. Se Max Pohlenz nel suo celeberrimo saggio “L’uomo greco” del 1945 difese la tesi che la civiltà greca si fondava sui profili letterari e politici rivolti alla ricerca del Vero, del Bello e del Bene, riaprendo le porte a valori umanistici di fonte raffaellita e vinciana; se la sua analisi rievocava l’uomo greco di fronte a se stesso, alla divinità e alla comunità; sarà il nostro Furio Jesi che, nella sua accuratissima lettura della “Germania segreta”, negli anni ‘70 rivedrà nella filologia classica europea, germanica e italica, il sotterraneo Leitmotiv della cultura occidentale. Proprio in suo saggio del 1967, Jesi ritornerà alla polemica fra Romagnoli e la scuola di Wilamowitz von Moellendorff, respingendo implicitamente la presunta superficialità della questione, così classificata dall’élite marxista italiana. La riscoperta del Mito nella cultura tedesca non fu soltanto un espediente estetico per colpire i lettori. Minerva, la virago greca che respinge sdegnata l’osceno abbraccio dello scimmione prussiano, disegnato efficacemente da Duilio Cambellotti sul frontespizio del libello del Romagnoli – rappresentava la consapevolezza di un Mito mera fonte dell’opera d’arte, strumento spesso utilizzato da alcuni manipolatori della cultura di un popolo per ottenere fini di parte. Perché una cosa è rivalutare l’originalità del Mito, altro è avvelenare la storia attuale con valori devianti e pericolosi alla società, magari per costituire interessi criminali e asociali. Una cosa è infatti l’onesta ricerca del Vero, del Bene e del Buono che hanno sede nel cuore dell’uomo, altra cosa ben diversa è la metodologia, che un cultore di una materia può adottare per favorire un suo fine, che lo rende un corifeo dell’orrido e dell’inganno, magari con l’idea di vestire falsità apparentemente vere. Questo forse fu in parte il messaggio di Romagnoli, intravvedere dietro la minuziosa arte dello spaccare il capello in quattro di molti filologisti tedeschi, il fatto che non solo dimenticavano la storia greca, ma anche la indirizzavano nel loro presente a fini illeciti, come testimoniava il truffaldino mercato delle cattedre universitarie che aprì la guerra alla germanolatria nelle facoltà italiane di primo ‘900. Certamente, il linguaggio ironico di Romagnoli nascondeva un suo afflato nazionalistico, non immune da altrettanto senso di risentimento allora diffuso in tempo di guerra, quasi in coincidenza col disastro di Caporetto, in quel 1917 molto simile al sentimento popolare in questo 2020 invaso dal corona virus. Ma il riscatto di Romagnoli nella cultura europea attuale, malgrado la reazione del Pohlenz e la mediazione dello Jesi, che ne capì forse unico, le ragioni, passa da quegli studi musicali oggi riscoperti e che presto lo riporteranno nella sua più giusta collocazione.