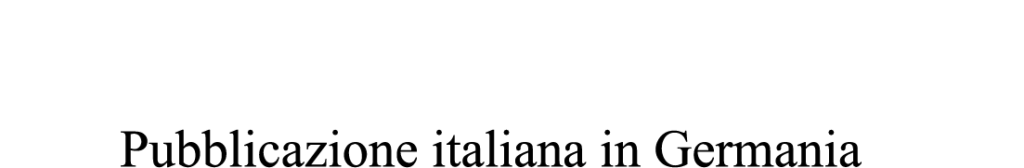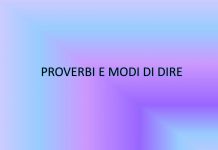È calato il sipario sulla Berlinale 2025 e come sempre il verdetto della giuria ha suscitato polemiche e rammarichi. L’edizione numero 75, la prima con la direzione artistica di Tricia Tuttle che ha preso il posto di Carlo Chatrian e Mariëtte Rissenbeek, ha consegnato l’Orso d’oro al film norvegese “Dreams’ (Sex Love)” di Dag Johan Haugerud, una pellicola senz’altro interessante e ben riuscita, centrata su tematiche queer (la vicenda riguarda una ragazza diciassettenne che nella odierna Oslo s’innamora della sua insegnante di francese). Nelle due edizioni precedenti il premio più prestigioso era andato a documentari; questa volta è stato assegnato ad un lungometraggio da carattere molto “letterario”. La pellicola vincitrice chiude una “trilogia delle relazioni” che era iniziata con “Sex” e proseguita con “Love”.

Orso d’oro a parte, fa piacere segnalare che una piccola soddisfazione se l’è presa anche il cinema italiano, che pure quest’anno era molto poco rappresentato, senza nessun film in concorso. Eppure, lo splendido documentario dei fratelli De Serio “Canone effimero” sulle tradizioni etnomusicali delle regioni italiane, presentato nella sezione Forum, è stato insignito di una “menzione speciale” per il Berlinale Documentary Award.
Tra le tante pellicole che ci è capitato di vedere durante il festival, in assenza di altri film italiani, ci pare una buona scelta soffermarci su due opere tedesche che trattano con delicatezza e profondità tematiche importanti della storia della Germania. Il primo è “Das deutsche Volk” di Marcin Wierzchowski, un toccante documentario sulla strage di Hanau del febbraio 2020, il più grave eccidio di matrice razzista della storia tedesca dopo la fine della Seconda guerra mondiale. I fatti sono noti: la sera del 19 febbraio del 2020 un ragazzo del luogo ha sparato nell’arco di pochi minuti a nove persone identificate dal loro aspetto come stranieri e dunque come nemici da abbattere. Il colpevole è poi tornato a casa, ha ucciso la madre e sé stesso. Il regista Wierzchowski, di origini polacche, emigrato con la famiglia in Germania e diplomato in cinema all’Accademia della Belle Arti di Magonza, rievoca l’evento ponendosi nella prospettiva dei famigliari delle vittime e dei sopravvissuti. Attraverso le loro parole e i loro volti ci vengono presentate le conseguenze a lungo termine per una città che ha vissuto una tragedia come quella. Per quattro anni il regista ha seguito alcuni dei famigliari documentando il modo in cui hanno provato ad affrontare ed elaborare il lutto, e la lotta che hanno intrapreso per ottenere, se non giustizia, almeno il riconoscimento della piena appartenenza al paese in cui vivono e lavorano da anni e che sentono come loro “casa”. Inutile dire che, al di là delle molte parole di compassione, si sono dovuti continuamente scontrare con una burocrazia fredda e cinica, propria di un sistema impreparato ad affrontare un crimine di quelle proporzioni, che non ha mai saputo dare risposte alle domande legittime che venivano poste. Senza contare la reazione di alcuni mass media che hanno rifiutato la pista razzista etichettando il caso come faide interne alle comunità di migranti. I famigliari accusano le autorità di essere stati informati con molto ritardo e mai in maniera completa sullo stato delle indagini, di avere sequestrato i corpi delle vittime e fatto eseguire l’autopsia senza il loro consenso. La preoccupazione maggiore delle forze dell’ordine sembra sia stata quella di prevenire eventuali reazioni di vendetta da parte dei famigliari, un’ipotesi che nessuno di loro in realtà ha mai preso in considerazione. Le scene più agghiaccianti sono quelle in cui i famigliari delle vittime incontrano i responsabili politici come l’allora ministro degli Interni dell’Assia Peter Beuth (CDU) o il sindaco di Hanau Claus Kaminsky (SPD), i quali non sono mai capaci di trovare le parole giuste per commentare l’accaduto, di scusarsi per gli errori compiuti dalle forze dell’ordine, per il modo in cui sono stati condotti i primi interrogatori. Sintomatica è la disputa attorno al progetto di erigere un monumento che ricordi i caduti della strage. I famigliari lo vorrebbero su Markplatz, la piazza principale di Hanau, dove sorge un monumento dedicato ai fratelli Grimm, che proprio ad Hanau hanno avuto i natali. La proposta viene respinta come se quei nove morti fossero qualcosa di estraneo alla storia della città e del popolo tedesco.

Un altro film di grande impatto è stato “Mit der Faust in die Welt schlagen”, opera prima della quarantenne Constanze Klaue, presentata nella sezione “Perspectives” della Berlinale 2025. Tratto dall’omonimo romanzo di Lukas Rietzschel, il film è un dramma famigliare ambientato nella provincia profonda della ex Germania orientale (una località della Sassonia al confine con la Polonia) nei primi anni del nuovo millennio. Vi si raccontano le peripezie della famiglia Zschornack attraverso lo sguardo dei due fratelli Philipp e Tobias, detto Tobi, sullo sfondo di un affresco sociale fatto di profondi sconvolgimenti e grandi disillusioni. In un paesaggio naturale idilliaco, fatto di foreste sconfinate, campi di colza gialli e laghetti d’acqua limpida in mezzo alle cave, accanto al quale vengono mostrate le rovine industriali della DDR, impianti ferroviari dismessi, nascosti da erbacce e cespugli, simboli di un mondo tramontato e non rimpianto. In questo film non c’è traccia di quel sentimento che è stato battezzato “ostalgia”. Il Muro e il comunismo sono ricordi lontani che tutti vorrebbero rimuovere per guardare al futuro. La nuova casa di proprietà, che il padre dei ragazzi sta costruendo da sé, è l’emblema di un nuovo inizio, oltre che un adattamento agli standard di vita occidentali. Ma il percorso verso il riscatto sociale ed economico è arduo: con la fine della DDR il padre ha perso il lavoro in fabbrica ed è caduto nell’alcolismo. Il suo amico Uwe, provetto operaio, accusato di essere stato informatore della Stasi, è totalmente emarginato dalla comunità.
Il destino dei due fratelli, che all’inizio della vicenda hanno rispettivamente 12 e 9 anni, prende strade diverse: il maggiore si sottrae alle miserie morali del luogo trasferendosi in una grande città, il più giovane cerca un modo per dare sfogo alla sua rabbia unendosi a un gruppo di ragazzi più grandi, che promettono avventure e divertimento, ma che di fatto sono attivisti della galassia neonazista e si divertono a insultare gli stranieri, disegnare svastiche e compiere atti di violenza xenofoba verso i rifugiati della zona. Molto intensa la scena in cui l’anziano bidello copre con dei panni il cippo su cui nottetempo stata designata una svastica, mentre gli alunni della scuola lo osservano sghignazzando, del tutto ignari del significato del suo gesto come anche della provocazione subita. La storia che viene raccontata è quella di una generazione che oscilla tra disorientamento e ribellione, illusione e frustrazione. Assolutamente da vedere.