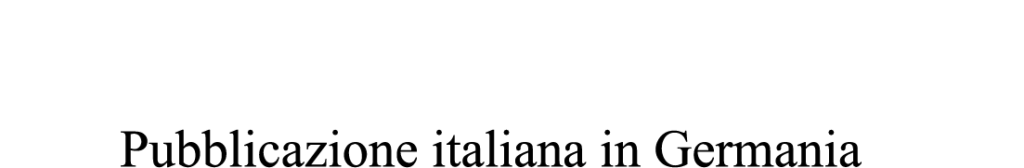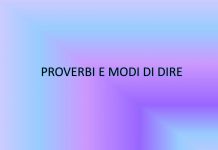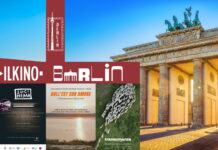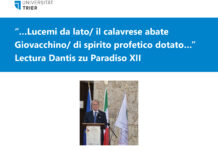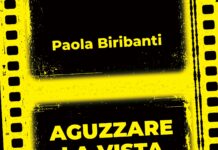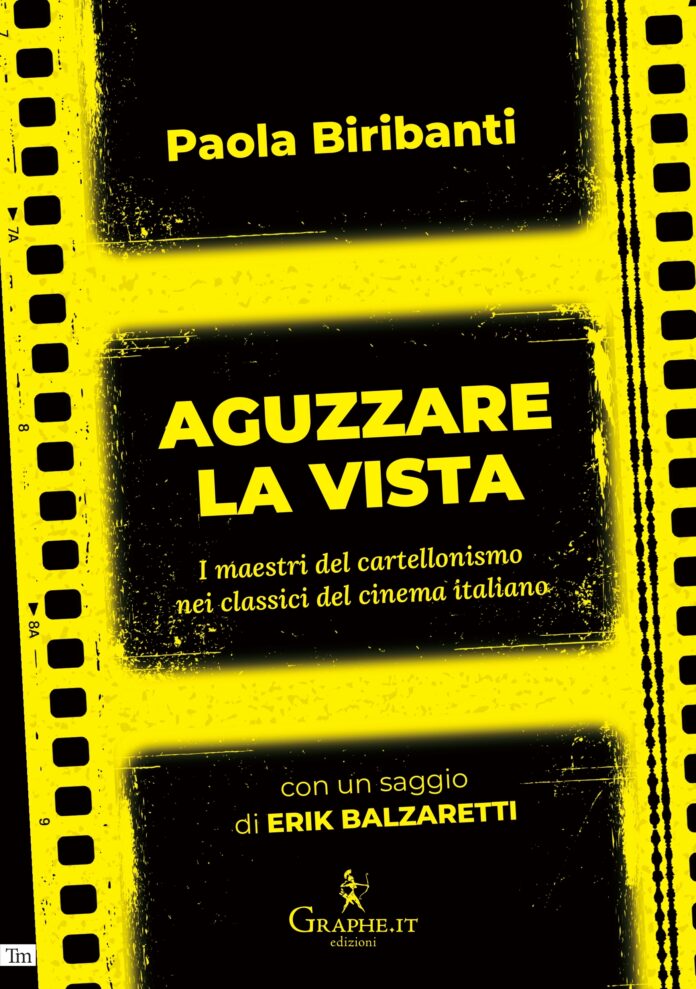„Aguzzare la vista“ di Paola Biribanti si presenta come un’indagine tanto meticolosa quanto illuminante sul cartellonismo pubblicitario all’interno dei classici del cinema italiano. L’autrice, con una prospettiva che intreccia sapientemente storia del cinema, dell’illustrazione e del marketing, conduce il lettore in un viaggio che abbraccia un periodo cruciale, dal 1930 al 1977.
La metodologia di analisi adottata dalla Biribanti si distingue per la sua capacità di restituire ai manifesti la loro funzione originaria di oggetti di consumo di massa, sottraendoli alla decontestualizzazione museale. Attraverso la lente del cinema, i manifesti riacquistano vita, svelando la loro importanza come testimonianze di un’epoca e come strumenti di comunicazione efficaci.
I riferimenti presenti nel libro sono vasti e accuratamente selezionati. L’autrice non si limita a citare i manifesti più celebri, come quello di Rita Hayworth in „Ladri di biciclette“, ma esplora anche il fenomeno del product placement ante litteram, rivelando la presenza di marchi pubblicitari all’interno delle pellicole. Questa analisi svela come, in un’epoca priva di normative specifiche, i marchi trovassero spazio nei film attraverso accordi pubblicitari, talvolta neanche troppo dissimulati.
L’analisi scrupolosa della Biribanti si estende anche alla selezione dei film presi in esame. L’autrice ha scelto di concentrarsi su veri e propri classici del cinema italiano, invitando il lettore a osservarli con occhi nuovi, soffermandosi su quei manifesti che, spesso, sfuggono a una prima visione.
„Aguzzare la vista“ si rivela un’opera fondamentale per chiunque sia interessato alla storia del cinema italiano e alla cultura popolare dell’epoca. Il libro non solo ci offre una nuova prospettiva sui manifesti pubblicitari, ma ci invita anche a riflettere sul ruolo della pubblicità nella società e sulla sua evoluzione nel tempo. Un’opera che, attraverso un’analisi approfondita e una scrittura coinvolgente, ci invita a „ri-vedere“ i classici del cinema italiano, scoprendo dettagli e significati nascosti.
L’abbiamo incontrata per voi.
Cosa l’ha spinta a intraprendere questa ricerca sui manifesti pubblicitari nei classici del cinema italiano? C’è stato un momento particolare o un’epifania che ha dato il via al progetto?
La ricerca è partita da un imprevisto, cioè da un brutto infortunio che per un paio di mesi mi ha costretta a casa. In quel periodo, avendo molto tempo a disposizione, ho iniziato a vedere film. La fine della riabilitazione ha coinciso con l’inizio del lockdown (era marzo 2020), per cui il tempo da dedicare ai film si è prolungato a dismisura. L’epifania c’è stata quando, guardando un film italiano degli anni Sessanta, sullo sfondo ho notato un manifesto di Gino Boccasile, il cartellonista che in passato è stato a lungo al centro dei miei studi. Dopo la sorpresa iniziale, ho pensato che, come avevo trovato Boccasile, nei film italiani avrei potuto trovare anche altri grandi della grafica pubblicitaria.
Perché ha scelto di limitare la sua analisi al periodo tra l’introduzione del sonoro e la fine di Carosello? Cosa rende questo intervallo di tempo particolarmente significativo per il suo studio?
Data la vastità del settore (la storia del cinema), una scelta andava fatta. Prendendo come campo d’indagine la produzione cinematografia italiana, ho scelto di partire dagli anni Trenta (l’introduzione del sonoro) e di finire con gli anni Settanta (la chiusura di Carosello) perché in quei decenni la pubblicità disegnata ha raggiunto il suo apice, sia come diffusione che come sperimentazione. Carosello, che negli anni Settanta proponeva ancora filmatini disegnati, rappresenta la propaggine estrema di quella stagione gloriosa.
Come ha selezionato i film da analizzare? Quali criteri ha utilizzato per scegliere i manifesti da includere nel libro?
All’inizio la ricerca si è svolta in modo disordinato, perché non riuscivo mettere a punto un criterio univoco. Sono partita concentrandomi di volta in volta sui registi, poi sui generi cinematografici… Alla fine ho optato per l’ordine cronologico. Per quanto riguarda i manifesti, in accordo con l’editore ho selezionato quelli più famosi, familiari anche a chi non si occupa di cartellonismo o di illustrazione. Manifesti che, “aguzzando la vista”, si riescono a scorgere anche in film straconosciuti. Basta solo spostare lo sguardo oltre i primi piani.
Nel libro sottolinea come la percezione attuale dei manifesti sia alterata dalla loro esposizione in mostre e musei. Può approfondire questo concetto e spiegare come i film ci permettano di “riappropriarci” della loro funzione originaria?
Il manifesto nasce come oggetto effimero, di consumo, lontanissimo dal concetto di musealizzazione. Oggi, invece, i manifesti del passato, specie quelli di maestri dell’arte dell’affiche come Dudovich, Boccasile, Pozzati o Cappiello, li possiamo vedere solo nei musei, nelle mostre o grazie a collezionisti, che li tengono prudentemente sotto chiave. Si fatica a pensarli esposti alle intemperie lungo le strade cittadine o attaccati ai muri degli edifici, anche se quella era la loro collocazione originaria.
Il libro evidenzia la presenza di marchi pubblicitari nei film, un fenomeno che anticipa il moderno product placement. Quali sono stati i casi più eclatanti o curiosi che ha riscontrato?
Tra i vari, mi viene in mente il caso de Gli uomini, che mascalzoni…, film di Mario Camerini del 1932. A pochi minuti dall’inizio avviene un litigio tra il protagonista, interpretato da Vittorio De Sica, e la giovane di cui è innamorato (Lya Franca). La sequenza è dinamica, perché i due camminano velocemente lungo una via di Milano. A un certo punto, però, si fermano a parlare, guarda caso davanti a un manifesto pubblicitario di Marcello Dudovich per un noto prodotto di bellezza.
Perché ha scelto di includere il celebre manifesto di Rita Hayworth in Ladri di biciclette, pur escludendo altri manifesti cinematografici? Cosa rende questo caso così speciale?
Più che la presenza di quel manifesto, è il ruolo dell’attacchino municipale ad avermi spinto a includere Ladri di biciclette nella ricerca. Dietro a un manifesto affisso c’è sempre un attacchino che ha lavorato. A volte ce ne dimentichiamo. Quello di Rita Hayworth non è l’unico manifesto presente nel film. Riguardandolo con attenzione ne ho notati altri, non solo cinematografici.
Quali sono state le principali sfide che ha incontrato durante la sua ricerca? Ci sono state scoperte inaspettate o momenti di particolare difficoltà?
La sfida è stata essenzialmente una, ossia cercare di capire se la presenza di un determinato manifesto era (ed è) pubblicità contrattata, inquadratura casuale o mera componente scenografica. Questa sfida ha rappresentato anche la maggiore difficoltà incontrata. Di inaspettato c’è stato il trovare manifesti anche in film che già conoscevo e che forse avevo visto in modo distratto o semplicemente in una fase della vita in cui non avevo ancora gli strumenti per riconoscerli.
Come vede il ruolo del cartellonismo nella storia del cinema italiano e nella cultura popolare dell’epoca?
I manifesti hanno rappresentato moltissimo non solo nel cinema, ma anche nella storia del disegno, oltre che in quella economica. Per molto tempo, insieme agli annunci sui giornali sono stati l’unico spazio pubblicitario esistente. Osservando i manifesti, anche all’interno dei film, si riesce a ripercorre la storia del costume di un Paese.
A chi si rivolge principalmente il suo libro? Quali sono le sue aspettative riguardo all’impatto che avrà sui lettori?
Credo che Aguzzare la vista sia il saggio più pop tra quelli che ho scritto finora. Potenzialmente si rivolge a tutti, non solo agli esperti di cartellonismo, di illustrazione o di cinema. Chi, d’altra parte, non hai mai visto almeno una volta Amici miei, Ladri di biciclette, Poveri ma belli o Venezia la luna e tu? Dalle persone che lo leggeranno mi aspetto che vadano a rivedere i film di cui parlo per verificare la presenza dei manifesti indicati o, magari, per scovarne anche degli altri.
Ha in programma di continuare la sua ricerca sul rapporto tra cinema e pubblicità? Ci sono altri periodi storici o aspetti del fenomeno che vorrebbe esplorare?
Ammetto che studiare il rapporto tra cinema e pubblicità è molto affascinante e non è detto che non ci ritorni sopra. Nell’immediato futuro, tuttavia, ho in programma di concentrarmi su un altro paio di progetti, sempre inerenti al mondo dell’illustrazione e dell’immagine riprodotta, a cui per ora preferirei non accennare per motivi puramente scaramantici.