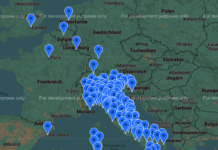A colloquio con Marco Guzzi
Caro Marco, oggi vorrei parlare con te di un tema di cui solo da poco si è cominciato a discutere più ampiamente, ma che tu fin dall’inizio della pandemia avevi già intuito e denunciato. Mi riferisco a tutti gli effetti collaterali e alle conseguenze che essa ha prodotto, che vanno ad esempio dal forte aumento dei casi di depressione tra i giovani – documentato recentemente anche da uno studio dell’università di Pittsburgh- all’abbattimento dei confini tra spazio privato e spazio lavorativo, alla didattica a distanza, che ha discriminato soprattutto le classi di per sé più disagiate; in Italia si parla ad esempio di 160 mila bambini che durante la chiusura delle scuole hanno perso l’opportunità di consumare l’unico pasto bilanciato della giornata. Sono solo alcuni dei tanti esempi. Pensi che nella scelta sulla gestione della pandemia si sarebbe potuto ragionare meglio sulle conseguenze di certi provvedimenti?
Credo che oramai dopo più di un anno dall’inizio di questa prova storica epocale, stiamo incominciando a fare dei ragionamenti più complessi sulle modalità che abbiamo assunto per fronteggiare il problema Covid e ci stiamo appunto interrogando su cose che a me erano sembrate evidenti fin dall’inizio. Dunque, quando si prendono provvedimenti restrittivi per ragioni sanitarie bisognerebbe, anzi bisognerà, tenere in considerazione tutti gli effetti collaterali e tutti i danni potenziali che queste misure, pur avendo evidentemente le loro ragioni, comunque provocano. Ulrich Beck dice che noi siamo una civiltà del rischio, cioè siamo entrati in una fase in cui il rischio è permanente. Lui fa riferimento ai cambiamenti climatici e all’inquinamento, però indubbiamente anche le pandemie, di cui tra l’altro si parla già dagli anni novanta, vi rientrano. Allora noi ci dobbiamo chiedere prima di tutto come possiamo convivere con una situazione di rischio di contagio; in secondo luogo quali sono le attività – che naturalmente con i dovuti protocolli – vanno comunque mantenute vive, anche correndo certamente dei rischi, ma sapendo che la loro chiusura ne determinerà altri, che fin’ora sono stati calcolati ben poco. Tu ne hai elencati alcuni ma sono moltissimi. Le conseguenze psicologiche, culturali, evolutive che noi stiamo causando a intere generazioni di ragazzi e bambini sono infatti molto difficili da misurare. La maggior parte degli psicologi e degli psicoterapeuti parlano di un trauma definitivo, qualche cosa che queste generazioni si porteranno dentro inevitabilmente. Certamente c’è una depressione, una mancanza di motivazione, un’asocialità, con poi possibili contraccolpi di violenza e autolesionismo che già emergono. Sappiamo inoltre che in questo anno centinaia di migliaia di persone non si sono curate, non hanno fatto le diagnosi per le malattie tumorali, non si sono fatti i controlli per le malattie cardiovascolari, con danni, anche qui, ancora poco chiari. Per non parlare del lavoro e di alcune categorie andate interamente distrutte. Mi riferisco ad esempio al settore della ristorazione, a quello alberghiero, all’intero comparto turistico, a quello relativo all’organizzazione di fiere, congressi ed eventi, ai lavoratori del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. In Italia si parla di centinaia di migliaia di piccole o medie imprese che hanno chiuso e che probabilmente non riapriranno mai più. Ma a parte questo aspetto, che a sua volta tra l’altro produce morte, malattie e suicidi, c’è anche questo effetto causato dal cosiddetto “smart-working” .
A questo proposito volevo chiederti se l’uso massiccio delle nuove tecnologie e le nuove forme di lavoro da remoto hanno avuto e avranno un impatto definitivo sui nostri stili di vita.
Sì, certamente queste nuove forme stanno proprio cambiando la concezione stessa del lavoro. Voglio dire, in futuro si potrà certamente ricorrere a delle modalità telematiche, ma credo che sarebbe disastroso pensare che tutto potrà essere svolto da casa. Il lavoro infatti, fin dall’origine dell’umanità, è un’attività preminentemente esterna, qualche cosa che ci porta nella socialità, che ne è un aspetto fondamentale. Un lavoro isolato è un attacco alla sua natura intrinseca – da sempre l’espressione che usiamo è appunto “andare a lavorare” – nonché alla capacità dei lavoratori di aggregarsi e di organizzarsi. Queste persone isolate in casa, con un terminale, saranno sempre di più del tutto schiave del loro datore, che potrà fare qualunque cosa, perché non c’è aggregazione e quindi solidarietà. Non ci si incontra a bere un caffè, a fare due chiacchiere. Non si sente l’unità del gruppo di lavoro. Quindi io credo che il rapporto con questa pandemia dovrà cambiare e dovremo diventare sempre più consapevoli che ognuna di queste restrizioni, anche se forse può avere un effetto positivo sul contenimento del contagio, può danneggiare gravemente altre situazioni. La politica del Covid andrebbe, a mio parere, radicalmente rivista, anche in prospettiva (speriamo di no) di una relazione ancora lunga con questo virus o con altri. Vogliamo passare qualche altro anno in questa situazione? Ma quanto può reggere il tessuto sociale ancora? Già stanno emergendo in tutta Europa manifestazioni anche violente contro queste misure. Il popolo che è già psicologicamente molto provato e devastato, potrebbe iniziare, come già sta facendo, a disobbedire.
Per chi volesse approfondire in lingua tedesca: www. darsipace.org. Facebook: Sich Frieden Schenken. Instagram: Frieden Schenken. Le pagine in italiano: www.darsipace.it. Facebook:darsi pace; Facebook: Marco Guzzi. I lettori possono scrivere al seguente indirizzo: kontakt@darsipace.org.